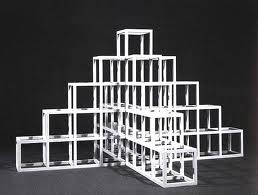Nella nostra mente rimangono impressi vividamente non solo persone, luoghi, fatti o personaggi, restano indelebili anche gusti, colori, profumi o situazioni (quali lo sciabordio del mare o il frinire delle cicale o ancora il rumore del vento fra gli alberi). I ricordi che vengono scatenati da queste sensazioni sono tanto più profondi quanto più esse sono intense, e hanno la capacità di riportarci indietro nel tempo, spesso direttamente alla nostra infanzia e al suo mondo magico.
Così, non posso stappare una gassosa, che il rumore del gas in uscita mi riporta direttamente al chiosco sul lungomare, dove il mio papà nelle sere di luglio ci comprava il succo di limone emulsionato con acqua ghiacciata, zucchero e bicarbonato; oppure non posso sentire l’odore del giornale appena stampato, perché immediatamente mi ritrovo sulla spiaggia, in fila per comprare la «zeppola» appena fritta, abbondantemente passata nello zucchero e cannella e appoggiata proprio sul giornale del mattino per farle «sudare» tutto l’olio in più…
… scusate, mi rendo conto che tutto ciò è molto «proustiano», ma mi serve per introdurre un argomento al quale tengo molto.
Se, infatti, sento nell’aria il classico profumo di dolce appena sfornato, il ricordo che si staglia chiaro e gigante nella mia mente è il babà! Lucido, di color ambrato, a forma di grosso porcino, con o senza crema, con o senza ciliegina, adagiato mollemente ad aspettarmi nella sua carta arricciata e piena di delizioso sciroppo di zucchero e rhum.

Per anni mi è stato detto (la mia prodigiosa prozia, seguita da mia madre e dalle sue sorelle) col sorrisetto agli angoli delle labbra: «é inutile cercare di rifare il babà a casa… tanto non verrà mai», ed io, ligia al divieto famigliare, ho sempre badato a comprarlo in pasticceria.
Ora però che sono fuori dall’Italia il babà dove lo trovo? Allora mi sono messa di buzzo e ho iniziato a provare tutte le ricette sulle quali sono riuscita a mettere le mani (libri, internet, una cugina lontana grande cuoca) fino a trovarne una che, almeno in parte, mi riportasse al delizioso sapore conosciuto.
Che gli avi mi perdonino per ciò che sto per dire !
In effetti, la ricetta che mi ha dato finora i migliori risultati non arriva da qualche voluminoso compendio di cucina napoletana o dalla bocca di un vecchio pasticcere che prende un po’ di fresco nel vico, ma… (ahimè) dal Mastering the art of French Cooking di Julia Child (sì sì proprio quella del film Julia and Julia interpretato da Meryl Streep).
Del resto, per placare le mie ansie, posso dire che il babà pare non essere stata neppure un’invenzione napoletana, infatti, risalgono alla metà dell’Ottocento circa le prime fonti partenopee, mentre notizie di un dolce simile ci arrivano addirittura dalla lontana Polonia. Il babka ponczowa, era, infatti, una specie di ciambellone che veniva riempito di crema, poco dolce e un po’ soffocante, che fu rivisitato dal sovrano Stanislao Leszczyński, che si dilettava di cucina, il quale, per renderlo un po’ più appetibile, lo «bagnò» per la prima volta con una miscela di Tokaj e zucchero!
Dunque vi passo la ricetta di Julia, aggiungendo qualche avvertenza preliminare:
Il babà è un gran signore e come un gran signore vuole essere trattato. Lavoratelo in un luogo caldo, ponetelo a crescere in posto lontano dalle correnti d’aria. Una volta cotto aspettate che l’umidità della pasta venga completamente eliminata prima di imbibirlo dello sciroppo. Può essere congelato facilmente e con successo, ma prima di essere inzuppato di sciroppo lo dovete far scongelare nel forno a 150 gradi per 5 minuti.
Che altro ? Ah, sì seguite le dosi (per 12 babà) e i tempi di crescita e cottura con esattezza. Darò la ricetta con le misure americane (tazze, cucchiai da tavola ecc.) perché non mi azzardo a farne la conversione (su internet si trovano programmi appositi e se non avete i misurini americani potete dilettarvi a convertire le dosi).
Pronti?
4 Tb di burro
1 Tb di lievito di birra fresco (che profumo!)
3 Tb di acqua calda
2 Tb di zucchero
un pizzico di sale
2 grandi uova
1 cup e 1/3 di farina
Mescolate l’acqua calda con il lievito finché si sia sciolto bene. Aggiungete le uova, lo zucchero e il pizzico di sale e lavorate finché tutto sia ben amalgamato con un cucchiaio di legno. Aggiungete la farina e continuate a mescolare. Ora, dopo che l’impasto è ben amalgamato, con la mano a coppetta continuate a impastare in modo circolare, poi staccate l’impasto dalle pareti, mescolatelo e sbattetelo violentemente contro di esse, ripetendo questa operazione, che sembra scema ma é fondamentale, per almeno 5 minuti. All’inizio l’impasto è appiccicoso e si incollerà alle dita, ma mano a mano che procedete con questa operazione si staccherà sempre più facilmente da dita e recipiente. Una volta arrivati ad una consistenza che vi permetta di tenere l’impasto in mano (senza cioè che scivoli via…) fatene una palla, con un coltello fate un’incisione leggera a croce e deponetelo in un contenitore, ricoperto con un panno pulito in un luogo caldo (fra i 25 e i 45 gradi) per 1 ½ – 2 ore.
Una volta cresciuto l’impasto (sarà enorme !) gentilmente con una mano staccatelo dalle pareti e dividetelo in 12 stampini da babà (se non li trovate vanno bene anche quelli per i muffin, il risultato finale sarà però un po’ diverso) già spalmati di burro e infarinati. Ora ai babà occorrono altre due ore di lievitazione, ognuno nel proprio stampino, nello stesso luogo caldo e senza sbalzi di temperatura e correnti d’aria, fino a che la pasta non arrivi quasi al bordo, prima di essere pronti alla cottura che dovrà essere breve ma intensa (250 gradi per 15 minuti).
Ce l’abbiamo quasi fatta !
Mentre i babà cuociono preparate lo sciroppo al rhum con
2 cup di acqua calda
1 cup di zucchero
½ cup di Rhum (quello scuro, se vi piace un po’ piu alcolico potete aggiungere altro rhum)
In un pentolino fate scaldare lo sciroppo finché tutto lo zucchero sarà sciolto. Togliete dal fuoco e fate raffreddare.
Quando i babà saranno cotti aspettate che si raffreddino e poi procedete al bagno nello sciroppo.
Se tutto è andato bene il risultato sarà dolcetti morbidi e spugnosi, ma sodi (tanto che se li strizzate ritorneranno alla loro forma) che affogati nel liquido si gonfieranno deliziosamente.
Alla fine potrete spennellarli con una miscela di marmellata di albicocche e acqua, che li renderà lucidi, ma io preferisco sbranarli così.