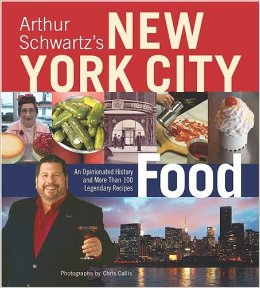16 ottobre 1968, Città del Messico, premiazione per la finale dei 200 metri. Sul podio tre atleti, due neri e un bianco. Lo scatto è iconico, racconta di un gesto fortemente simbolico, coraggioso, che cambierà in modo tragico l’intera vita dei protagonisti. A capo chino, scalzi e con il pugno guantato alzato due atleti statunitensi, Tommie Smith e John Carlos, primo e terzo classificato, ascoltano in silenzio l’inno americano, a rivendicare la tutela dei diritti dei cittadini afroamericani. Quasi in primo piano un giovane bianco Peter Norman, australiano, un fenomeno sportivo che verrà punito per aver osato tanto, condivide con i primi due il grido di ribellione silenzioso, portando al petto lo stemma del Progetto Olimpico per i Diritti Umani.
Il 1968, come ho già raccontato altrove – 50 anni e non sentirli: nel cuore del ’68 – fu l’anno in cui le contestazioni giovanili giunsero al loro apice non solo in Europa. Negli Stati Uniti il disastro del Vietnam, una guerra infinita che decimò l’intera generazione dei ragazzi nati fra gli anni 40′ e 50′, tutti chiamati alle armi, alimentava il dibattito e sopratutto le violenze non solo fra gli studenti. Alcuni episodi di inusitata brutalità portarono agli scontri con la polizia e il potere costituito all’interno delle Università di tutto il Paese. Ad essi si sovrapposero fatti gravissimi come l’assassinio di M.L. King e quello di Bob Kennedy. Nel resto del pianeta il mondo andava in fiamme: il Maggio francese, la primavera di Praga, il massacro di My Lai e la strage di Piazza delle Tre Culture proprio a Città del Messico, solo per citare gli episodi più famosi.
In questo clima arroventato iniziarono le Olimpiadi di Città del Messico del ’68.
Nel tempo le Olimpiadi non hanno solo rappresentato la festa dello sport, ma spesso si sono trasformate in eccezionale vetrina di propaganda politica e sociale. Dove, infatti, meglio che davanti a milioni di spettatori si può dimostrare la potenza di uno stato o, al contrario, le istanze di rivolta e dissenso? Gruppi politici e individui – non solo i regimi – sono da sempre consapevoli dell’impatto che un grande evento sportivo può suscitare. Che dire del massacro dei palestinesi di Settembre nero a Monaco nel 1972, in cui persero la vita 11 atleti israeliani e che innescò un crescendo di vendette reciproche. Come non ricordare gli anni del boicottaggio delle Olimpiadi, quando a turno i paesi dei due blocchi contrapposti rifiutavano di parteciparvi. O ancora ultimamente le polemiche nate durante le Olimpiadi invernali di Sochi in Russia, bollate come palese dimostrazione dell’imperialismo russo di Putin. E ancora la plateale reazione di Colin Kaepernick, ex quarterback dei 49ers e di alcuni suoi compagno di squadra, che durante le esecuzioni dell’inno nazionale si sono rifiutati di alzarsi in piedi in solidarietà con le rivendicazioni dei movimenti per i diritti civili e in palese contrasto con il presidente Trump.

Sport e politica sembrano essere dunque quasi inseparabili, ma se i regimi totalitari e nazionalisti hanno usato e usano a tutt’oggi lo sport come veicolo di propaganda e di supremazia, assoggettandolo a logiche di potere, la preferenza va invece a quei gesti di disobbedienza civile attraverso lo sport che sono mirati a dare una scossa alla società, a far fremere di indignazione, affinché diritti basilari dell’uomo siano riconosciuti e preservati, affinché ingiustizie e razzismo vengano svelati e combattuti anche sui campi da gioco.